 IL SIGNOR PERGIUNTA
IL SIGNOR PERGIUNTA
Gabriele Bianchi
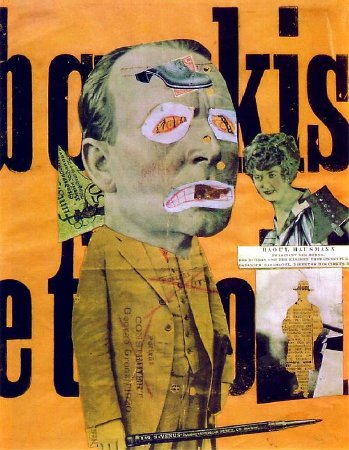
Un tipo inconcludente, lo si sarebbe definito così.
Uno che a una prima occhiata sembra a posto, ma poi più lo si conosce più viene il dubbio di essercisi sbagliati. No, non un incapace, ma un indolente, un pigro, uno in grado di arrivarci a tanto così e poi perdersi in un bicchiere d’acqua: uno di quelli di cui a scuola dicevano «è intelligente, ma non si applica». E non sarebbe stata una cosa del tutto negativa, se solo Alberto non ne avesse abusato in ogni faccenda quotidiana, dal lavoro alla famiglia alle amicizie. La sua vita si costellava di avvenimenti vari, tutti legati dalla superficialità e dalla leggerezza, dalla particolare perizia nello schivare impegni e doveri. Ma in fin dei conti era riuscito comunque a proseguire il suo giro di vita, che lo aveva portato dal quasi centro di Milano alla periferia di Altopascio, fuori Lucca.
Una catena di eventi mancati, così l’immaginava nella sua testa, che si manifestavano uno dopo l’altro in una processione nera o grigia non lo sapeva, ma lugubre, tristemente lenta e infinita: eventi minimi, nei quali scorgeva la piega che la sua vita avrebbe potuto forse prendere.
Iobbéstia, gridava il suo capo, è possibile che tu debba sempre rifare gli stessi errori?! Ioccàne, te l’ho detto ieri e l’altro ieri ancora – ringhiando.
Sì ha ragione, mi scusi, ero distratto, e intanto nella sua testa ronzava il conto progressivo dei soldi in nero che giravano in ditta e mentalmente ne aggiornava l’importo, chissà mai gli tornasse utile. Rimuginava su come questo discorso del nero andasse sempre liscio: non c’erano spie, delatori, agenti travestiti da rappresentanti, e quindi per forza tutto filava; si chiedeva soprattutto come facesse quell’uomo a dormire tutte le sante notti, almeno – diceva – terrà sempre un occhio aperto e uno chiuso, no?
Gli ritornava lo stesso pensiero balenato pochi giorni prima, inseguito all’ennesima sfuriata del capo, e cioè di andarsene, cambiare lavoro, aria; e invece era restato tranquillo sul suo sediolone, attendendo che la tempesta finisse: troppo pigro per cambiare lavoro, sapeva che lì dentro non sarebbe mai cambiato nulla, tantomeno lui. Nemmeno la vecchia segretaria e le sue unghie laccate di rosso se ne sarebbero mai andate: nonostante biascicasse a stento il proprio nome, era di una precisione maniacale e soprattutto aveva memoria, una memoria infallibile, quella che il capo aveva cominciato a smarrire dopo tanto tempo immerso negli affari. Di sicuro non stava bene che gli altri notassero in lui la seppur minima mancanza: alla testa di un piccolo impero familiare, impreziosito dai tradimenti alla moglie e dalla dipendenza dalla droga del figlio maggiore (mentre intanto la piccola faceva di tutto per passare per la più troia del paese), bè insomma in quanto capo non poteva avere né cadute né cedimenti, e il più piccolo scricchiolìo del suo cervello non doveva essere notato all’esterno, e anzi ridotto e rimosso in fretta, come un brutto ricordo. E dato che tutto doveva passare da lui, sotto i suoi occhialini rotondi appollaiati sulla punta del naso grosso e unto, agli altri rimaneva ben poco da fare se non obbedire.
Poi, certo, la responsabilità si traduce in tempo da togliere a qualcosa che ti piace e a metterlo in qualcosa che normalmente non ti piace, come il lavoro, ma che per lo meno è remunerato. Non troppo, mi raccomando, giusto il necessario; meno male che c’era un po’ di nero che placava il dispiacere. Non troppo nemmeno di quello, di dispiacere, perché poi la sera, tornato a casa, se non altro le pantofole, il divano e lo strapuntino dove appoggiare i piedi lo aspettavano con impazienza. Ogni sera uguale, sempre uguale, come un fiume sempre sporco o la scìa della ciminiera nel cielo dalle otto meno un quarto alle diciotto. Così da circa dieci anni, che a pensarci bene erano passati in un attimo, senza che nessuno (tantomeno lui) se ne accorgesse. La moglie era invecchiata senza pretese, abbandonando una certa freschezza e floridità per conquistare autorità e peso; anche la bimba pareva invecchiata più che cresciuta. Dieci anni nei quali era riuscito in sequenza: a nascondere a Francesca una mezza relazione con una tizia conosciuta al bar a mezzogiorno, che era proseguita fra sotterfugi vari fino ad essere quasi beccato con i soliti messaggini sul cellulare, dei quali si era pateticamente giustificato. Tuttavia, poco dopo era stato scoperto in pieno mentre parlava con la stessa donna, e alla fine, fra le scenate generali, era scoppiato un pandemonio e lui, in lacrime, aveva giurato e spergiurato che non l’avrebbe fatto più, pur sapendo perfettamente che la moglie non ci avrebbe creduto. Francesca, allora, aveva preso a compatirlo, a chiamarlo il poverino quando parlava di lui con le amiche – questo Alberto era venuto a saperlo per caso, ma non se l’era presa più di tanto e lasciava correre. La cosa più triste risiedeva nel fatto che solo Alberto credeva ormai alle proprie scuse, patetico fino al midollo, un midollo marcio e puzzolente come una fogna intasata; magari il suo midollo era intasato di brutto e non riusciva a far scorrere granchè di roba lì dentro, in quello che lui immaginava come un tubo lungo e grigio che passava in mezzo alle vertebre e che si conclude da qualche parte più sopra, forse nel cervello, ma non ne era sicuro. La certezza era solo il male alla spalla, che si era presentato una mattina recandosi in ufficio, sotto forma di quella che poteva essere ben definita una frescata, che lui stesso definiva una frescata e che anche il suo capo definiva una frescata, quindi per forza doveva essere così ioccàne, perché tanto voi non capite nulla. Ma che, trascorso qualche mese, crescendo di intensità il dolore in un punto imprecisato fra l’omero e la spalla, in un fascio muscolare sommerso dalla pelle e da un altro muscolo floscio, si ergeva ben tirata quest’altra fibra, dura come un legno, che gli faceva un male cane. E aveva cominciato a imbottirsi di un farmaco che si faceva arrivare direttamente dalla svizzera, ah gran paese la svizzera non c’è che dire, ma che purtroppo gli procurava alcuni inconvenienti, come l’alito cattivo e una certa flatulenza, scoreggiava insomma, facendo di tutto per non farsi accorgere. In ufficio, seduto sulla sedia, gli bastava inclinarsi leggermente verso sinistra, contrarre per bene le chiappe e spingere delicatamente con gli addominali, al limite premendosi con la mano dove l’intestino fa quella curva fra il crasso e il tenue. Il bugiardino parlava di effetti collaterali lievi, amplificabili da una soggettiva intolleranza ai singoli principi attivi contenuti nel farmaco e di rivolgersi al medico in caso di gravi disturbi, perché quelli potevano ben esserlo. Che poi magari c’era anche un’interazione con i nervi - di cui una sua parente un tempo aveva sofferto - che si rilasciavano improvvisamente, e quindi il controllo dei muscoli interni avrebbe potuto andare a farsi fottere e lui scoreggiare allegramente perché non poteva fare altrimenti. Infatti, qualunque valvola, orifizio, muscolo pelvico deputato a trattenergli le viscere e ciò che queste contenevano era potenzialmente esposto alle insidie dell’intruglio svizzero, ah gran paese la svizzera. Dopo aver prodotto, si rimetteva ordinatamente in posizione, spostando il peso al centro e cominciando a sbuffare forte dal naso perché la puzza non salisse e rimanesse confinata per lo meno nelle vicinanze di dove era uscita; questo gioco non sempre gli riusciva alla perfezione, e allora lo vedevi alzarsi di fretta, per smuovere l’aria, mentre quasi correva verso il bagno nel tentativo di fare da esca a quella puzza tremenda che gli era scappata. Tutto questo per il male alla spalla.
Intanto incrociava furtivo gli occhi della collega di fronte, fino a che questa non abbassava lo sguardo, forse per l’odore forse per la noia di stare a guardare un viso inespressivo come il suo. Se poi capitava che il capo gli starnutisse addosso, lei ridacchiava tutta ebete, senza voltarsi dal pic poc sulla tastiera del pc. Bisogna dire che il capo non lo faceva per cattiveria, era più una sbadataggine, come se non si fosse ricordato di portare la mano alla bocca oppure un’improvvisa paralisi l’avesse colpito alle braccia, impedendogli qualunque movimento.
Ecco, le mani: l’unica cosa che avevano in comune erano le mani: piccole, delicate, non avvezze ad alcun tipo di lavoro manuale, di un rosa più chiaro rispetto all’incarnato del volto, con le unghiette fini sempre rosicchiate.
Chi invece si curava (e parecchio) del proprio aspetto era la polacca che il capo stipendiava regolarmente ogni mese, stornando i soldi dalla cassa: un giorno Alberto l’aveva incontrata per strada, mentre lei usciva dal centro estetico e lui si dirigeva affamato alla rosticceria dei cinesi a comprare qualcosa per la cena, poiché Francesca non c’era, per il turno di notte in comunità. E comunque lei aveva smesso di preparargli quasi qualunque cosa, dal caffè la mattina ai vestiti stirati; gli faceva solo il bucato, alle volte nemmeno quello, e gli urlava che lo portasse a lavare da sua madre quella santa donna, ioccàne. Bestemmiava anche, quello sì, sempre più frequentemente e non era buon segno. Sua madre si sarebbe fatta il segno della croce sei volte se l’avesse sentita; se poi per disgrazia fosse entrata in ufficio in uno di quei momenti proprio concitati come è la stupida normalità, lì allora sarebbe di sicuro svenuta, investita dal volume degli insulti diretti ai vari “sottoposti” (così il capo amava definire i propri dipendenti), insulti di durezza commisurata alla cazzata commessa. Quanto mai…
Alberto rifletteva anche sulla fortuna accumulata dall’inventore dei post-it, di cui il suo capo era un gran consumatore: ne attaccava ovunque, ci scriveva sopra di tutto, male e in fretta, lettere commerciali da riprodurre fedelmente, cosa ha scritto qui non si capisce ma che cosa vuoi che ci sia scritto: colisage, cartone, imbecille e testa di cazzo per giunta, proprio così aggiungeva, per giunta, come se non bastasse essere imbecille; proprio a lui era toccato in sorte un fallito analfabeta di quel genere, uno che “per giunta” era pure una testa di cazzo. Per giunta poteva anche essere un’unica parola, tutta condensata in poche lettere diverse: immaginava alle volte di scriverla fuori dall’ufficio il giorno in cui si sarebbe licenziato, o forse era meglio aspettare un po’, così da sviare i sospetti; altre volte si vedeva intento a coprire quell’altra scritta in viola sul muro di cinta della fabbrica, k… vecchia troia ti ucciderò, meglio coprirla con un meno volgare ma altrettanto perentorio PERGIUNTA, tutto attaccato e in stampatello. Così il vecchio l’avrebbe per forza vista ogni giorno tornando a casa, col cellulare attaccato all’orecchio e la mano a mezzogiorno sul volante, come un camionista: gli mancava solo il piolo per somigliarci davvero.
Inserito nella routine preordinatata di tutti i giorni, Alberto si sentiva un fantasma alle dipendenze di un signor pergiunta, che gli ordinava di fare cose, come farle, senza mai la necessità di spingersi oltre perché sennò è un casino, e poi chi lo sente. La sua vita si era appiattita piano piano, come una spirale di carta riposta sul tavolo, senza nessun bimbo che ne tiri il lembo centrale e se la trascini dietro per farla volare; rimaneva lì, come un aquilone morto a terra, esanime e floscio. Avrebbe potuto sentirsi un numero come dicono molti, ma in ogni caso non un intero, no un intero no; una frazione di uomo al più, ecco sì, una frazione, perché l’altro pezzo se l’era perso chissà come. Oltretutto era convinto che un giorno (al momento giusto) il suo licenziamento avrebbe causato dei problemi ai colleghi, grandi casini, ah quando c’era lui andava tutto meglio; più che altro lo sperava per affermare la propria insostituibilità: nessuno è indispensabile, gli ricordava però una vocina nell’orecchio… E poi, perché avrebbero dovuto rimpiangere una frazione d’uomo, qualche centesimo d’uomo? uno come lui: ingobbito e con le ciglia aggrottate a riconciliare gli estratti conto, le fatture, le tasse, senza alcun fiato sul collo, ma con il proprio alito puzzolente che ogni tanto si faceva vivo coi rigurgiti acidi della gastrite “da inutilità”, così la chiamava. Sì perché di solito la gastrite viene a quelli che se la prendono, a quelli che si incazzano anche conto terzi; ma questo di sicuro non era il suo caso, e allora l’aveva classificata in quel modo. Ma lo sapeva che tanto erano le pasticche per la spalla ad aprirgli quella voragine nello stomaco, che inghiottiva dispiaceri e ansie senza restituire nulla, nemmeno un po’ di sollievo alla spalla. Infatti, il chiropratico da cui si era recato per l’acuirsi del dolore nell’ultima settimana gli aveva consigliato un intero ciclo di sedute, e soprattutto di fare una vita meno sedentaria, meno stress e compagnia bella. Ma che stress, dottore, qui è il contrario, gli avrebbe voluto dire, è il contrario perché io di tensioni esterne non ne ho per nulla, nessuno mi scarica addosso nulla. Aveva solo questa strana cosa, come un macigno su una spalla, come se un tizio che non vedeva da un sacco di tempo gli avesse dato una bella botta per salutarlo, con amicizia, fraternità, cameratismo eccetera. Tuttavia il dolore rimaneva, e magari era davvero psicosomatico come sosteneva quell’altro amico che si intendeva un po’ di psicologia e medicine naturali. Vedi, c’è un disagio alla base, qualcosa di inespresso che ti tieni dentro e ti concentra la tensione sulla spalla: prova i fiori di Bach, oppure un massaggio olistico, anche il cranio-sacrale sarebbe perfetto. Ma pareva dimenticare tutto questo poiché alla fine di ogni giornata il suo pensiero andava sempre alla stessa cosa: con la moglie accanto nonostante tutto, la bimba che dormiva nella stanzina di là col gatto in mezzo alle gambe, si chiedeva: cosa ci faccio qui? Era l’unico concetto intelligente della giornata, che lentamente traduceva in parole e a bassa voce, nella speranza che la moglie non lo sentisse, visto che la pronunciava davvero, non nella testa. E se anche lo sentiva tanto meglio, perché forse anche Francesca si faceva la stessa domanda, e forse anche più spesso di lui; allora sarebbe stata lei a chiederglielo, bisbigliando. Che lo sentisse pure, così finalmente la donna avrebbe preso le redini della cosa per liberarlo (comodamente) di quel peso dopo un’ottima litigata, magari dicendogli che era meglio prendersi un periodo di pausa; ma Francesca gli era sempre parsa con un po’ più di testa sulle spalle rispetto a lui, nonostante i turni di notte massacranti alla comunità psichiatrica – quindi in un modo o nell’altro ci sapeva fare coi matti, non sarà mica matto anche lui? – e Alice, la bimba assillante messa al mondo in un breve momento di felicità coniugale, prima che Lara e poi Simona si inserissero fra di loro. Che ci faccio qui un giorno l’aveva chiesto anche al gatto, intento a pisciare nella lettiera piena di bentonite del discount, ma nemmeno questi gli aveva prestato troppa attenzione e finiti i suoi bisogni gli si era un po’ strusciato addosso, andandosene via a buco ritto, miagolando.
Che ci fai lì glielo chiedeva anche sua madre la quale, da aristocratica decaduta con sigaretta lunga e castigata vita monastica dedicata ai poveri, assisteva al tracollo del suo unico figlio, ai suoi occhi non tanto sciagurato quanto “diverso”, così lontano dalle sue aspettative. Era proprio lui che, durante una delle ultime furiose litigate con suo padre (esattamente quella in cui Alberto aveva annunciato la decisione di trasferirsi in Toscana da Francesca), era lui che aveva osato barattare un impeto d’orgoglio nei confronti di un padre troppo assente per qualcosa vicino a un grande affetto misto a senso di responsabilità verso la futura mamma di Alice, che sarebbe nata di lì a qualche mese. Nonostante la contrarietà di entrambi i genitori - e glielo avevano detto che era un incosciente e che non avrebbe avuto il loro appoggio - , Alberto testardo aveva scelto l’amore, inimicandosi definitivamente il padre, mentre la madre si era mantenuta più diplomatica, riprendendolo, redarguendolo come si fa con un bambino, ma senza troncare i rapporti. Poco male, si era detto cinicamente: almeno lei sta con me. La frittata si era conclusa poco dopo con il divorzio dei suoi, con i ventisei anni di Alberto appena laureato tante speranze e compagnia bella, e il padre che si era messo con una brasiliana di una vita e mezzo più giovane di lui. Iobbéstia, avrebbe urlato il suo capo, tutte le fortune all’altri. Ma tanto fortunato non era stato, perché dopo sei mesi era crepato di infarto (secondo la madre era per il viagra che si ingollava di continuo pur di andare con quella “sgualdrina”, concludeva stizzita) e aveva lasciato tutto alla brasiliana, che nel frattempo era già ripartita per il suo paese, portandosi via i soldi e anche l’argenteria. Per i due superstiti, erano allora iniziati i problemi: prima la causa per l’eredità, poi l’ictus della madre che le aveva bloccato mezza faccia, e poi le infinite piccole economie che lui stesso era stato costretto a mettere in atto per mantenere la propria famiglia, la madre e anche l’amante, con la quale nel frattempo aveva riallacciato un po’ i rapporti.
In un modo o nell’altro, le donne - che fossero madri, mogli, suocere - l’avevano un po’ rovinato, rifletteva alle volte mezzo assopito, sbracato di fronte alla tele con la birra in mano; ed era tutto eccitato al ricordo di quando, quel pomeriggio d’inverno, aveva riaperto gli occhi e si era ritrovato davanti la figlia del capo: la testa che saliva e scendeva dolcemente su di lui. Aveva subito compreso, in quel momento, di aver fatto la più grossa inutile stronzata della sua vita, del rischio che correva; oltretutto, in quel momento non aveva proprio presente per quale astrusa combinazione di fattori fosse riuscito in quell’impresa, ma poco gli importava. Di sicuro le aveva dato un passaggio dalla fabbrica a casa: il vecchio, subissato di cose da fare prima della partenza per la Corea, prevista per il pomeriggio stesso, gli aveva detto seccamente «Portala a casa, grazie» (quell’inusuale gentilezza, quel grazie gratuito a cosa era dovuto?). Come un pezzo intercambiabile dei macchinari che uscivano dalla fabbrica, si era allora volentieri prestato anche a fare l’autista, mansione che sua madre avrebbe piuttosto nobilitato come chauffeur, ma faceva lo stesso. La ragazza, che razzolava spesso per gli uffici quando non aveva scuola, lo aveva fissato come solo una diciassettenne in calore poteva fare, e lui non ci aveva pensato su due volte, interpretando quello sguardo come un insensato invito a cui rispondere con educazione naturalmente di sì, senza meravigliarsene più di tanto, senza chiedersi perché proprio lui.
Sarebbe poi ritornato in ditta, con addosso ancora l’odore della giovane, per una stretta di mano vigorosa al capo; tutto sorridente come non lo era mai stato, con il vecchio che quasi si insospettiva per quell’improvvisa allegria su quel volto così ordinario, ma che in un impeto di generosità gli augurava buon natale, iobòno. Egli ringraziò e sembrò quasi prostrarsi in un mezzo inchino, come un paggio, un buffone, un giullare di corte di fronte al suo sire.
Per contattare l'autore Gabriele Bianchi scrivete a ga.bianchi@libero.it

 Precedente Successivo
Precedente Successivo
 VENTONUOVO VENTONUOVO  Copertina
Copertina
|