|  IL MANICOMIO
IL MANICOMIO
– brano del romanzo Il conformista –
Alberto Moravia
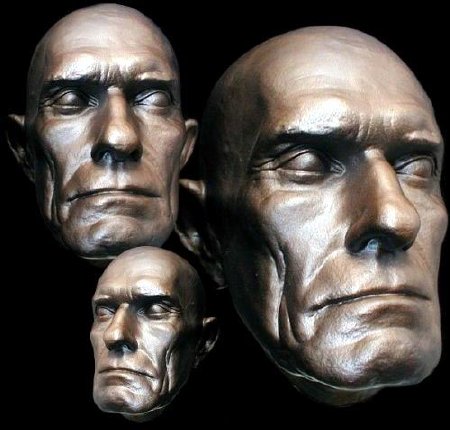
(…) Discesero e si avviarono verso il cancello della clinica. La strada si trovava in un quartiere tranquillo, ai margini di un’antica villa reale. Era una strada breve: da una parte si allineavano cinque o sei palazzine vecchiotte in parte nascoste tra gli alberi; dall’altra correva la cancellata della clinica. In fondo, sbarrava la vista il vecchio muro grigio e la folta vegetazione del parco reale. Marcello visitava suo padre almeno una volta al mese da molti anni; tuttavia non si era ancora abituato a queste visite e provava ogni volta un senso mescolato di ribrezzo e di sconforto. Era un po’ lo stesso sentimento che gli ispiravano le visite a sua madre, nella villa in cui aveva passato l’infanzia e l’adolescenza; ma tanto più forte: il disordine e la corruzione materna sembravano ancora riparabili; ma per la pazzia del padre non c’erano rimedi ed essa pareva alludere ad un disordine e ad una corruzione più generali e del tutto insanabili. Così, anche questa volta, entrando in quella strada a fianco di sua madre, egli sentì piegare le ginocchia. Capì di essere diventato pallido e, per un momento, pur guardando di sfuggita alle lance nere della cancellata della clinica, provò un desiderio isterico di rinunziare alla visita e allontanarsi con un pretesto. La madre, che non si era accorta del suo turbamento, disse fermandosi davanti un piccolo cancello nero e premendo il bottone di porcellana di un campanello: “Sai qual è la sua ultima fissazione?”.
“Quale?”
“Quella di essere uno dei ministri di Mussolini… gli è cominciata da un mese… forse perché gli lasciano leggere i giornali.”
Marcello aggrottò le sopracciglia ma non disse nulla. Il cancello si aprì e apparve un giovane infermiere in camice bianco: corpulento, alto, biondo, con la testa rasata e il viso bianco e un po’ gonfio. “Buon giorno, Franz”, disse la madre graziosamente. “Come va?”
“Oggi stiamo meglio di ieri”, disse l’infermiere con un suo duro accento tedesco, “ieri siamo stati molto male.”
“Molto male?”
“Abbiamo dovuto indossare la camicia di forza”, spiegò l’infermiere continuando ad adoperare il prurale, un po’ alla maniera leziosa delle governanti quando parlano dei bambini.
“la camicia di forza… che orrore.” Intanto erano entrati e camminavano per lo stretto viale, tra il muro di cinta e la parete della clinica. “La camicia di forza, dovresti vederla… non è veramente una camicia ma come due maniche che gli tengono le braccia ferme… prima di vederla, io pensavo che fosse una vera e propria camicia da notte, di quelle con la greca in fondo… è così triste vederlo legato a quel modo con le braccia strette ai fianchi.” La madre continuò a parlare leggermente, quasi allegramente. Girarono intorno la clinica e sbucarono in uno spiazzo, davanti la facciata principale. La clinica, palazzina bianca di tre piani, aveva un aspetto di normale dimora, non fossero state le inferriate che oscuravano le finestre. L’infermiere disse, salendo in fretta la scala sotto il verone: “Il professore vi aspetta, signora Clerici”. Egli precedette i due visitatori in un ingresso nudo e in ombra, e andò a picchiare ad una porta chiusa, al di sopra della quale, su una targa smaltata, si leggeva: “direzione”.
La porta si aprì subito e il direttore della clinica, il professor Ermini, ne scaturì, precipitandosi, con tutta l’irruenza della persona torreggiante e massiccia, incontro ai visitatori. “Signora, i miei omaggi… dottor Clerici, buongiorno.” La sua voce stentorea risuonava come un gong di bronzo nel silenzio gelato della clinica, tra quelle pareti nude. La madre gli tese la mano che il professore, piegando con sforzo visibile il corpaccione avviluppato nel camice, volle galantemente baciare; Marcello, invece, si limitò a un sobrio saluto. Il professore nel viso somigliava assai a un barbagianni: occhi grandi, rotondi, grosso naso ricurvo, a becco, baffi rossi spioventi sopra la larga bocca clamorosa; ma l’espessione non era quella del malinconico uccello notturno, bensì gioviale, seppure di una giovialità studiata e venata di fredda accortezza. Egli precedette la madre e Marcello su per la scala. Come giunsero a metà della rampa, un oggetto metallico scagliato con forza dal pianerottolo rotolò rimbalzando sugli scalini. Nello stesso tempo echeggiò un grido acutissimo seguito da una sghignazzata. Il professore si chinò a raccogliere l’oggetto: un piatto di alluminio: “La Donegalli”, disse voltandosi verso i due visitatori, “niente paura… si tratta di una vecchia signora di solito tranquillissima che, però, ogni tanto le piglia di tirare quanto le capita sotto mano… eh eh, sarebbe campionessa di bocce, se la lasciassimo fare”. Egli porse il piatto all’infermiere e si avviò chiacchierando, per un lungo corridoio, tra due file di porte chiuse. E come mai signora, ancora a Roma? Io vi credevo già in montagna o al mare.”
“Partirò tra un mese…”, disse la madre. Ma non so dove andrò… per una volta vorrei evitare Venezia.”
“Un consiglio signora”, disse il professore girando intorno l’angolo del corridoio, “andate a Ischia… ci sono stato proprio l’altro giorno in gita… una meraviglia… siamo andati nel ristorante di un certo Carminiello: abbiamo amngiato una zuppa di pesce che era semplicemente un poema. “Il professore si voltò a metà e fece un gesto volgare ma espressivo con due dita all’algolo della bocca: “Un poema, vi dico: tocchi di pesci grossi così… e poi un po’ di tutto: il polpettello, lo scorfanello, il palombetto, l’ostricuccia tanto buona, il gamberetto, il totanuccio… e tutto con un sughillo alla marinara… aglio, olio, pomodoro, peperoncino… signora non dico altro”. Dopo avere adottato, per descrivere la zuppa di pesce un falso e giocoso accento napoletano, il professore ricadde nel nativo romanesco, soggiungendo: “Sapete cosa ho detto a mia moglie? Vuoi vedere che dentro l’anno ci facciamo la casetta a Ischia?”.
La madre disse: “Preferisco Capri”.
“Ma quello è un luogo per letterati e invertiti”, disse il professore con distratta brutalità. In quel momento si udì giungere da una delle celle uno strido acutissimo. Il professore si avvicinò alla porta,a prì lo spioncino, guardò un momento, richiuse lo spioncino e, quindi, girandosi, concluse: “Ischia, cara signora… Ischia è il luogo: zuppa di pesce, mare, sole, vita all’aperto… non c’è che Ischia.”
L’infermiere Franz, che li aveva preceduti di qualche passo, adesso aspettava, immobile presso una delle porte, la figura massiccia disegnata nel chiarore della finestra che stava all’estremità del corridoio. “Ha preso la posione?” domandò a bassa voce il professore. L’infermiere accennò di sì. Il professore aprì ed entrò, seguito dalla madre e da Marcello.
Era una piccola stanza nuda, con un letto fissato alla parete e un tavolino di legno bianco di fronte alla finestra sbarrata dalle solite inferriate. Seduto al tavolino, le spalle alla porta, intento a scrivere, Marcello, con un brivido di ripugnanza, vide suo padre. Una sfuriata di capelli bianchi si levava dalla testa, sopra la nuca esile imbucata nel largo collo della rigida casacca di rigatino. Stava seduto un po’ di sghembo, i piedi infilati in due enormi pantofole di feltro, i gomiti e le ginocchia in fuori, la testa reclinata da un lato. In tutto simile, pensò Marcello, ad un burattino dai fili rotti. L’ingresso dei tre visitatori non lo fece voltare; anzi egli parve raddoppiare di attenzione e di zelo nella scrittura. Il professore andò a mettersi tra la finestra e il tavolo e disse con falsa giovialità: “Maggiore, come va, oggi… eh come va?”.
Il pazzo non rispose e si limitò ad alzare una mano come per dire: “Un momento, non vedete che sono occupato”. Il professore lanciò uno sguardo d’intesa alla madre e disse: “Sempre quel memoriale, eh, maggiore… ma non verrà troppo lungo?... Il duce non ha il tempo di leggere cose troppo lunghe… lui stesso è sempre breve, conciso… brevità, concisione, maggiore”.
Il pazzo fece di nuovo quel cenno con la mano ossuta agitata in alto, quindi, con una sua strana furia, lanciò, per aria, al disopra della testa chinata, un foglio di carta che andò a cadere nel mezzo della sala. Marcello si chinò a raccoglierlo: non conteneva che poche parole incomprensibili scritte in una calligrafia piena svolazzi e di sottolineature. Forse non erano neanche parole. Mentre esaminava il foglio, il pazzo cominciò a lanciarne degli altri, sempre con lo stesso gesto furiosamente indaffarato. I fogli volavano al di sopra della testa canuta e si sparpagliavano per la stanza, Via via che lanciava i fogli, i gesti del pazzo si facevano sempre più violenti e tutta la stanza adesso era piena di quei figlietti di carta quadrigliata. La madre disse: “Povero caro… ha sempre avuto la passione di scrivere”. (…)
(Tratto dal romanzo Il conformista, Bompiani editrice, Milano, 1951.)

Alberto Moravia

 Precedente Successivo
Precedente Successivo
  Copertina
Copertina
|