 TESEO
TESEO
Roberto Piumini
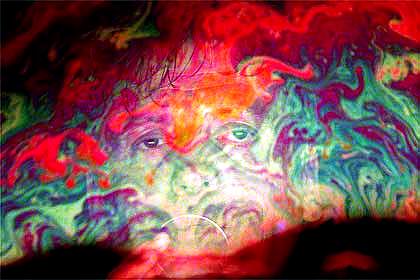
Levate in alto le coppe perfettamente lustrate, sopra le quali, annuncio dell’ebbrezza futura, un dio buffone ci mostra le nostre facce deformi e, per suo gioco, ci dona
un’apparenza porcina.
Fate cessare le danze, e la musica sciolta lasci il silenzio alla lira. più adatta a cantare. I servi cessino tutti di trasportare vivande, anche il vino, cessate, sì, lo ripeto, cessate,
quello che è in tavola basti.
Qualcuno faccia tacere quei giovani, laggiù, quelli là sotto il portico, battete forte gli anelli sul metallo dorato, che smettano, con rispetto, la loto rozza allegria, e ascoltino la storia
del coraggioso Teseo!
Il ferocissimo mostro, nato dall’orrido amore di Pasife per il gran toro, il Minotauro, era stato imprigionato dal padre, il potente Minosse, in un palazzo intricato,<
il labirinto di Creta.
Della colpa di Pasife anche Minosse era pieno: lui era stato, un giorno, a offendere Poseidone, che per punirlo aveva suscitato l’amore, impuro e orrido amore,
fra la sua sposa e il toro.
La colpa è un fiume, un lago, un oceano, vedete, che non si forma a montagne, a catene di monti. L’acqua del suo dolore circonda tutta la terra, e trascorre, si muove,
e alle caviglie ci tiene.
Ogni anno, crudele con la minaccia di attacco, il re di Creta chiedeva agli ateniesi una nave con sette giovani e sette ragazze vergini ancora, intatti fiori dell’Attica
per nutrire quel mostro.
Arrivati a Creta, erano trascinati nel labirinto, e rinchiusi, e tentando una fuga senza speranza, impazziti, ognuno di loro dal mostro era trovato, e divorato, fra grida,
in quel giorno d’orrore.
Poi, sazio, il mostro restava, lordo di sangue e capelli, a digerire il suo pasto per un anno, fin quando, preso da nuovo appetito, lanciava un alto muggito, che risuonava nel cielo,
segno di lutto ad Atene.
Giovane era Teseo, nato da Etra ed Egeo, il sovrano di Atena. Era un guerriero, con occhi splendidi di coraggio, il corpo magro ma forte, e i capelli arruffati,
profumati di miele.
Disse a sua padre: “Io vado, ucciderò quell’orrore e salverò centinaia di giovani ateniesi. Io ho imparato, a Trezene, a combattere, padre, con le mie sole mani,
non ho paura di niente”.
“Che, al ritorno, la nave abbia le vele bianche, se sarai vivo, o nere, se quel mostro ti uccide.” Questo fu detto, e Teseo, con le tredici vittime, in un clamore di pianto,
salpò dal vasto Pireo.
Eccoli a Creta, piangenti, anche Teseo: ma fingeva, e fra le dita guardava intorno a sé. Quando Arianna, figlia maggiore del re, disse con pallido volto, e voce quasi dolente:
“Chi sarà il portavoce?”
“Io” lui rispose, e di un passo si fece avanti, e il vento, soffiando dal monte Ida, gli scompigliava i capelli. E fu lui che alla cena sacra, offerta dal re, ospite pronto alla morte,
rappresentò gli ateniesi.
Era una cena di festa, era una cena di lutto. Si brindava a Gea e si invocava Ade. Teseo guardava Arianna, lei guardava Teseo. E quello sguardo che i due si davano, non era
uno sguardo da niente
C’erano danze di gioia, con sette danzatrici provenienti da Kasso, con nastri rossi ai capelli, e un anello nel labbro e larghe vesti turchine. E Teseo le guardava
nei loro salti, tacendo.
C’erano danze di lutto, con dieci danzatrici venute da Santorini, l’isola di pietra nera. Tutte portavano lacci intorno al collo, di seta, e gemme sopra la fonte,
e Teseo le guardava.
C’erano suonatrici, trenta, di Milo, Fenicie, della Sicilia, di Tiro, e de Egiziane, con seni che perdevano latte, e flauti, timpani e cetre, pifferi, fischi e sonagli,<
e Teseo le guardava.
E c’era Sòrine e altre cinque sorelle di Arianna, tutte minori, gentili, che, mescolate alle serve, portavano bevande. Sòrine era sorda, ma facilmente leggeva parole sopra le labbra,
e Teseo la guardava.
E lo guardava Arianna, e pensava a una gioia, ma le battevano in petto colpi di orrore, perché il fratellastro lo avrebbe, nel labirinto, sbranato: non c’era scampo per lui,
e si torceva le dita.
Alla fine del pasto si alzò Teseo, per andare dove gli altri ateniesi aspettavano in pianto. Disse Arianna, passando: “Trovati, amico mio, quando la notte finisce,
alla finestra orientale”.
Dentro la cella, abbracciati, o solitari, i ragazzi destinati alla morte aspettavano il giorno, con gli occhi chiusi, o sbarrati, in un brusio di lamenti, pallidi, senza energia:
così Teseo li trovò.
Qualcuno cadde nel sonno, sognando grida, qualcuno si accoppiò disperato, mischiando lacrime e baci, dandosi graffi e carezze, e con la testa chinata, solo in disparte, dolente,
li ascoltava Teseo.
Quando le dita dell’alba tinsero il cielo ad oriente, Teseo, muovendosi adagio, piegò le gambe nerbute presso la bassa finestra che si osava di sole, e appoggiò le sue mani
alla stretta fessura.
Ci fu una voce che disse, piano, bisbiglio di fronde: “O giovane ateniese profumato di miele, forse sarai divorato, forse non lo sarai, tendi una mano, e prendi, se vincerai, se vivrai,
questo ti aiuti ad uscire”.
E una mano gli tese un gomitolo grosso come una piccola mela, o una pesca d’aprile. Era di un filo di seta del colore del sangue, un sangue appena più scuro, piccolo e cupo sole,
era il più fine dei fili.
Ma, con sveltezza, Teseo, invece di quella palla, prese il polso sottile che gliela porgeva, e lo strinse deciso, anche se il polso cedeva, non accennava a fuggire, e lo tenne Teseo
fra le sue umide dita.
“Tu sei Arianna?” “Lo sono.” “Perché mi aiuti sapendo che voglio uccidere il mostro, che è tuo fratello, sebbene solo da parte di madre, tutti lo sanno: un fratello
a metà solamente?”
“Io non lo so, ateniese profumato di miele. Chiedilo ai miei capelli: da ciascuno di essi mi viene, nella mente, una voce che dice, forte e dolcissima insieme.
“Salva quel giovane, Arianna!”
“Se io mi salvo, e ritorno” le bisbigliò Teseo, “ti porterò ad Atene, dove sarai mia sposa, e madre dei miei figli, con onore e amore. Prepara una veste, semplice e bianca, che sia
veste di nozze, o di lutto.”
Fioco era il bisbiglio: nessuno c’era a sentire, fra le rose lì intorno, in quel silenzio di alba. Nessuno c’era, nessuno, giacché nessuno appariva, attorno, nell’aria fresca
fra quelle rose fiorite.
Nessuno c’era, perché niente lì si muoveva: né i fusti spinosi, né le piccole foglie, né i bei petali rosa che profumavano il cielo, come un fiato di Dei: tranne Arianna, nessuno,
nessuno c’era, nessuno.
E niente si sentiva sulla morbida terra, attorno a quella cella, dove, svegliati dall’alba come da un cane nel cuore, fuori dagli incubi, svegli, al vero incubo, ancora,
davano i giovani un grido.
Lame di trombe squillarono tutto intorno al palazzo dalle infinite pareti, dove il mostro correva, eccitato dai fumi dei sacrifici di fuori, scavando solchi sul suolo,
pazzo di fame e furore.
Sopra un carro tirato da quattro buoi color latte, vennero le quattordici vittime, fiori d’Atene, e dietro a quello, appiedati, con rami freschi, in silenzio, vestiti di bianco lino,
Minosse e la sua corte.
A ciascuno dei giovani furono tolte le vesti, perché il mostro non fosse strozzato da quei tessuti, e perché nessuno potesse entrare con delle armi, o con sostanze nascoste,
per uccidere il bruto.
E non pensavano certo che i denti di quei ragazzi, che battevano forte, per un gelo d’orrore, fossero armi proibite, e così non guardarono, non fecero attenzione
alle bocche imploranti.
E non guardarono in quella, chiusa e silenziosa, del giovane Teseo, dove, segreta ciliegia, muto immobile frutto, stava il gomitolo rosso che gli era stato donato
dalla mano di Arianna.
Dentro, un roco muggito rispondeva alle trombe, con soffi e raschi, una furia. A quella musica orrenda, ogni anno, là a Creta, per tutto il giorno, nel cielo, dall’alba fino al tramonto,
non volavano uccelli.
E fu aperto il portale, e furono spinti, pressati, nudi e tremanti, all’interno, i quattordici giovani, e fu rinchiuso il portale, e incatenato di nuovo, perché restasse sbarrato
fino al prossimo anno.
E gridavano rochi battendo i pugni e le mani contro il portale richiuso, e imploravano “Aprite!” invocando gli Dei, e appoggiando la fronte, ma le trombe suonavano e coprivano, forti
quei richiami d’orrore.
Le trombe tacquero, poi, e fuori si sentiva solo quell’urlo corrente, quei cozzi e raschi del mostro contro gli angoli tetri del labirinto, e il silenzio, lo spaventoso tacere
delle vittime chiuse.
Tredici, senza più voce, affranti, spiando intorno, si lanciarono verso inesistenti rifugi, inesistenti pertugi, inesistenti passaggi che li portassero fuori, o li tenessero vivi,
in quella casa di morte.
Solo Teseo, ascoltando, andava verso quel grido, e srotolava in cammino il filo rosso, che prima, svelto, aveva legato a un chiodo, al portale: e nessuno, lì intorno, incuriosito, chiedeva:
“Che stai facendo, Teseo?”
Tredici corpi tremanti, con corse brevi, con corse brevi, da topi, con le orecchie guizzanti, cercavano di allontanarsi dal grande urlo in arrivo: ma, per percorsi impensati, come un tremore di terra,
il Minotauro veniva.
Solo Teseo, srotolando la lunga lenza che aveva, andava verso quel grido, cercava il mostro: ma sempre un’improvvisa parete, o un angolo cieco, lo ingannava, sempre
l’orrido urlo era altrove.
Finché, al di là di pareti, sentì un bramito più corto, e un lungo strillo umano, l’ultimo di uno che muore, e poi più niente, un silenzio, dentro il silenzio più urlato,
dei disperati in ascolto.
E poi riprese la corsa dell’invisibile mostro, oltre le cento muraglie di pietra rossa e scura: e Teseo, furibondo, srotolando il suo filo, accecato dai muri, lo inseguiva e cercava,
sempre cadendo in inganni.
Un alto strillo di donna risuonò poco dopo nel labirinto, lontano: una specie di fischio direttamente dal cuore, simile a quello di madre quando un figlio le muore:
quella a se stessa moriva.
E corse, urli, silenzi, e altre corse: Teseo ascoltava, sudando, e srotolava il suo filo, e lottava, piangendo, col desiderio di andare, lasciare il filo, e cercare, fiutando l’aria, ascoltando,
il suo orrendo nemico.
Al tredicesimo strillo, all’ultimo silenzio, Teseo finì il suo filo: come se fosse, quel filo, il filo di quelle vite una ad una troncate, dalle pallide Parche. Allora si fermò, e restò fermo, in attesa
del Minotauro, tacendo.
Come un sangue perduto da una ferita di spillo, dietro a lui si stendeva il filo rosso, sottile. Tenendolo fra le dita, ansimando, piangendo, il giovane Teseo, sudato al collo e alla fronte,
fermo nel posto, aspettava.
Ascoltava la corsa che il mostro faceva verso di lui: e per chiamarlo, perché arrivasse più in fretta, alzò furente la voce, e gridò senza sosta, guardando il cielo, Teseo:
“Teseo! Teseo! Teseo!”
“Teseo! Teseo!” gridava, guidando con la sua voce la corsa del mostro. “Teseo! Teseo! Teseo! e il suo nome, vagando per le stanze infinite del labirinto, faceva
un groviglio di echi.
Il Minotauro sbucò da dietro un angolo, orrendo, e gli pendeva da un corno un brandello di gamba, una caviglia sottile, di ragazza, leggera, e gli uscivano a ciuffi, di diversi colori,
dalla bocca i capelli.
E si fermò, a gridare quel suo roco bramito, e a raspare il terreno con la sua zampa, scrollando, senza riuscire, quel pezzo di carne umana dal corno, e cercando nell’aria
il profumo di Teseo.
Teseo lasciò cadere il capo del filo rosso e allargò, svelto e deciso, le gambe forti, un poco piegandole al ginocchio, e girò il torso, veloce, e lentamente, invece,
sollevò il pugno all’orecchio.
Laggiù a Trezene, un maestro, gran lottatore d’Oriente, aveva fatto imparare al giovane Teseo un duro colpo, una botta data dal pugno ben chiuso, scagliata contro il bersaglio
con la sveltezza del lampo.
Prima rami leggeri, dopo dei rami più grossi, robusti e duri, di peso. Teseo aveva imparato a troncare di colpo, con il suo pugno veloce, in una mossa soltanto,
accompagnata da un grido.
Quando era partito, via dalla sua giovinezza, e dalla dolce Trezene, Teseo era capace di abbattere una giovenca con un colpo soltanto. Ma il Minotauro era grande: aveva forse sei volte
la forza di una giovenca.
Fermo, a gambe allargate, Teseo aspettava, guardando il figlio di Pasife e del toro che, grave di carne e di sangue, indugiava e grugniva, e scuoteva il gran capo, e le due corna tremende,
preparando l’attacco.
Poi si lanciò ruggendo contro Teseo, che aspettava: quando arrivò, incontrò il pugno dell’ateniese, duro e potente, compatto, dritto fra le due corna rosse di sangue, scagliato
come una freccia di carne.
Schizzò via la caviglia, fra molte bave nerastre. Si fermò il mostro, stordito, traballando, pesante, e dalla bocca sorpresa, rimasta aperta, insieme a raggrumati capelli,
vomitò carne umana.
Con un balzo, Teseo, saltò di fianco, piegato sotto uno dei corni, e di nuovo, veloce, allargate le gambe, sollevò il pugno, e di scatto, breve fulmineo volto, colpì con quello la bestia
all’altezza del cuore.
Il Minotauro piegò le gambe scure, villose, abbassò il capo e il torso, batté i rudi ginocchi contro il molle terreno, cadde di fianco, scalciando due o tre volte, perdendo fiele, e rimase
fermo del tutto, per sempre.
Il Minotauro era morto. Teseo raccolse il capo del filo tra le sue dita, e riavvolgendolo, piano, senza alzare lo sguardo oltre la linea dei muri, un passo dopo un passo,
ricominciò a camminare.
Perché teneva quel filo? Perché non lo seguiva, camminandogli accanto? Perché lo raccoglieva in un gomitolo, ancora? Forse voleva che il mostro, restasse lì, non trovato,
nell’oblio della morte?
Oppure, forse, voleva portare il filo ad Atene, e in una sacra teca, tre volte al giorno incensata, farne un omaggio agli Dei? Forse voleva mostrarlo ai suoi figli futuri, a stupefatti nipoti,
dopo il lungo racconto?
Non ogni cosa che accade, non ogni cosa compiuta, nella commedia dei giorni, ha una ragione, o uno scopo. Spesso, la mano dell’uomo svolge, o avvolge, soltanto,
un suo segreto pensiero.
Arrotolando quel filo, ripercorreva Teseo il complicato cammino, e osservava, attorno, quel silenzio di pietra, lo sterminato palazzo, tetro, intricato e ombroso, quell’arnia cupa di morte,
tredici volte muta.
E ripensava ad Arianna dalla tiepida pelle, alla sua fronte lucente, alle spalle rotonde, ai seni chiari e sospesi, alle sue labbra dischiuse, poco vogliose di cibo,
mentre lui la guardava.
E si ingrossava, adagio, il gomitolo rosso fra le sue dita contuse, misto alla sabbia giallastra del labirinto. Teseo non si affrettava, girando la sua piccola palla, un passo dopo ogni passo,
nel gran silenzio del sole.
Ed ecco accadde l’evento che non da tutti è saputo: storia diversa, racconto che non fu mai raccontato, forse perduto, o sparito, ucciso dalle mutezze, o, per qualche ragione,
tenuto chiuso e segreto.
A una svolta, oltre uno dei cento angoli scuri, degli angoli infiniti, in uno slargo di muri, Teseo vide il filo che, sul terreno, arrivava a un groviglio, ad un groppo.
un grosso nodo improvviso.
E da quel nodo imprevisto non continuava il filo, non un filo soltanto, ma molti e molti, decine, che si spargevano intorno, in direzioni diverse, per un po’ uniti, e poi
ognuno per una strada.
Tornò davvero, Teseo, pieno di gloria, ad Atene? Lasciò davvero, spergiuro, là sulle pietre di Nasso, la malinconica Arianna? Quel che si sa è che, al ritorno, erano nere le vele,
e che si uccise Egeo.
Quale Teseo fu quello che a Delo propose grandiose feste ad Apollo, e che più tardi riunì la sparsa Attica in una, o che scoccò la sua freccia, insieme ad altri eroi,
sul mostro di Calidone?
Chi fu, davvero, a rapire la bella Ippolita, o tenne il piccolo Acamante sulle paterne ginocchia, e aiutò Pirìtoo nel rapimento di Elena? E fu veramente quello il Teseo che discese
a sfidare l’Inferno?
Forse riuscisti, Teseo, con infinita pazienza, a disfare quel nodo, trovando, il rosso, unico filo che Arianna ti diede, e lo seguisti, e compisti, come si narra, davvero,
il tuo glorioso cammino?
O nel tentare, impaziente (giacché non sempre infinita è la pazienza di un uomo) rompesti il filo, e si perse, in quel groviglio, quel solo, come si perde fra gli altri, nell’ampia foce assolata,
un ruscello nel Nilo?
O li seguisti, Teseo, uno ad uno, paziente (poiché a volte infinita è la pazienza dell’uomo) fino a trovarne la fine? E, uno ad uno, scopristi che non portavano fuori,
tranne quell’ultimo, il solo?
Oppure c’era un’uscita per ogni filo, Teseo? E chi aspettava, alla fine di quelle fughe infinite? Forse un labirinto non è un luogo che chiude, senza rimedio, qualcuno,
ma che gli apre ogni via.
Nulla sappiamo. Il racconto è fermo là: rimane davanti al nodo sanguigno, a quel groviglio impensato, a quell’imbroglio d’amore, cuore non svolto, segreto, matassa chiusa, sorpresa,
vene infinite del cuore.
Teseo, capelli di miele, in quel roseto, il silenzio, quanti silenzi teneva! Quante tese fermezze stavano, presso ogni foglia, prima dell’alba, in attesa, in quel fermo roseto!
Ah, quanti sguardi, Teseo!
(Tratto dalla raccolta di poesie Il piegatore di lenzuoli, Nino Aragno Editore, Torino, 2008, postfazione di Milva Cappellini)

Roberto Piumini (Edolo, 1947) oltre a numerosi libri di poesie, prose e teatro per bambini e per ragazzi, ha scritto i romanzi La rosa di Brod (1995), Caratteristiche del bosco sacro (2000), Gli eredi della terra (2002) e L’ultima volta che viene il vento (2002).

 Precedente Successivo
Precedente Successivo
  Copertina
Copertina
|