|  CAPIRÀ
CAPIRÀ
Piergiorgio Bellocchio
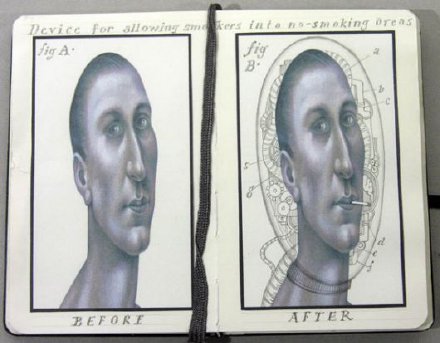
L'insegnante di matematica in ginnasio era un uomo poco più che quarantenne devastato da una malattia contratta, mi sembra, in Africa. Una malattia incurabile, progressiva, che se lo mangiava vivo e avrebbe finito l'opera entro un paio d'anni. Si trascinava con l'aiuto di un bastone, ma ogni movimento, perfino il respiro, pareva costargli fatica e dolore. L'effetto era ancor più penoso perché quelle gambe che procedevano a sussulti, quel tronco rattrappito dentro abiti troppo grandi, quel viso segnato da una smorfia di disgusto lasciavano intravedere, se anche non ci fosse stato detto da chi l'aveva conosciuto prima della malattia, di essere appartenuti a un bell'uomo, vigoroso, atletico addirittura. Durante le sue lezioni ci sforzavamo di tenere a freno la normale turbolenza dei nostri quattordici-quindici anni, con un riguardo che non avremmo riservato a nessun altro insegnante. Se la sua tragedia ci incuteva pietà, timore, rispetto, egli godeva anche del prestigio di aver giocato alla fine degli anni Venti per un paio di stagioni in una squadra di calcio di serie A. Talvolta, quando appariva meno sofferente del solito, ci azzardavamo a sollecitargli il racconto di qualche episodio di quella sua giovanile esperienza o lo chiamavamo a giudice delle nostre dispute sportive (il calcio era allora per molti di noi forse il massimo valore, quasi lo scopo dell'esistenza): lui, come rianimato e un po' commosso, non si sottraeva alle nostre affettuose pressioni. Senza però concedere nulla, neanche in quei momenti, al cameratismo.
Ci trattava col “lei”, come fossimo già liceali. Probabilmente la sua rigorosa imparzialità dipendeva dal fatto che realmente non ci distingueva l'uno dall'altro. Eravamo nomi, non persone: non gli restava abbastanza forza per essere incuriosito, attratto o respinto dalle nostre peculiarità e differenze, per coltivare simpatie e antipatie. Quando il male mordeva con particolare crudeltà, bastava una minima infrazione disciplinare, una parola sbagliata a fargli perdere il controllo. Esplodeva in urli quasi ferini, battendo furiosamente il bastone sulla cattedra, e in un paio d'occasioni fece anche il gesto di usarlo contro qualcuno di noi.
Apparteneva alla razza di coloro che vogliono fare il proprio dovere a tutti i costi, ma per quanto s'impegnasse allo spasimo contro le difficoltà di articolazione delle parole, e nonostante la speciale attenzione che gli prestavamo, le sue lezioni non potevano essere un modello di perspicuità. Sicché, se quasi sempre sapevamo reprimere la richiesta di un supplemento di spiegazione, accadeva pure ogni tanto che uno studente dimentico pronunciasse il rituale “Professore, non ho capito”. “Capirà, capirà... ” era la risposta. La battuta produceva sempre un effetto d'ilarità nella classe, liberata dall'imbarazzo prodotto dall'inopportuna richiesta del compagno. Ma a pochi poteva sfuggire il senso allusivo di quell'esausto e ironico “capirà”. Capirà questo problema di algebra, lo capirà da sé, per poco che s'impegni, senza che io debba torturarmi a rispiegarglielo... di tempo ne ha... E capirà altre cose, da sé, senza bisogno di spiegazioni... Capirà che scherzo feroce è la vita... Ma non c'è fretta... Perché dovrebbe capirlo subito? (... E poi, chissà... se ha un po' di fortuna, potrebbe anche non capirlo mai...)
(Brano tratto da Dalla parte del torto, Einaudi, Torino, 1989.)

Piergiorgio Bellocchio è nato nel 1931 a Piacenza, dove vive. Nel '62 ha fondato la rivista “Quaderni piacentini” e l'ha diretta fino alla chiusura, nel 1984. Tre suoi racconti sono stati pubblicati nel volume I piacevoli servi (Mondadori 1966). Ha collaborato con l'editore Garzanti scrivendo voci per l'Enciclopedia della letteratura (1972) e per l'Enciclopedia Europea (1976) e prefazioni a Stendhal, Dickens e Casanova. Dal '77 all'80 ha diretto a Milano la piccola casa editrice Gulliver.

 Precedente Successivo
Precedente Successivo
  Copertina
Copertina
|
