|  GABOLATRIA
E GABOFOBIA
GABOLATRIA
E GABOFOBIA
Héctor
Abad
 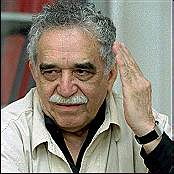
Si racconta che poco tempo fa Gabriel García Márquez abbia invitato
alcuni amici nella sua casa in Messico per festeggiare una cosa che in genere
gli scrittori non festeggiano: due anni senza scrivere una riga. Il suo primo
ritiro è avvenuto quasi dieci anni fa, quando si è dichiarato "giornalista
a riposo". Poi, come se volesse arrivare passo dopo passo al silenzio, ha
deciso di andare in pensione anche come scrittore. Alcuni dei suoi personaggi
finiscono a consumare la loro vita in silenzio sotto l'ombra di un albero. Per
fortuna Garcia Márquez non ha compiuto questo passo verso il mutismo. Che
un uomo dotato del dono prodigioso di rendere sublimi le cose più semplici
abbandoni l'esercizio che è stato la ragione della sua esistenza è
senza dubbio un po' triste. Ma d'altronde, se c'è qualcuno che si può
permettere questo silenzio senza sentirsi in debito, è proprio lui: un
genio artistico - unico nella storia della Colombia - che con la forza e il fascino
della sua immaginazione solitaria ci ha regalato leggende, miti e racconti che
altre culture elaborano in secoli di pazienza e con l'aiuto di molti scrittori
e poeti.
Con Garcia Márquez si rischia sempre di cadere nell'idolatria
(nella gabolatria, per essere più esatti) ed è per questo che nel
suo paese e in tutto il mondo c'è anche una setta che professa la devozione
opposta, ovvero la gabofobia. La sua più nota debolezza, l'attrazione fatale
per chi detiene il potere, ha permesso ai suoi detrattori di approfittare dell'unica
crepa nella sua imponente personalità: la tragica amicizia con un dittatore
moribondo dei Caraibi e la condiscendenza verso molti uomini di potere, compresi
tutti i presidenti colombiani dopo Julio César Turbay.
È molto
difficile essere così famosi, accettare il contatto con i potenti e riuscire
a sfuggire alla loro viscida stretta di mano. Per questo lo stesso Garcia Márquez,
a volte, deve ricordare con nostalgia l'epoca lontana in cui lo chiamavano Trapoloco
("stracciopazzo" , per i colori sgargianti delle sue camicie e dei suoi
calzini), gli anni in cui poteva dire sciocchezze senza che i giornali trasformassero
le sue parole in un oracolo, in cui con serenità e segreta altezzosità
poteva dirsi che a nessuno importava del suo futuro e meno che mai del suo futuro
di scrittore. Quando lo scherzo di una sera il giorno dopo diventa la sentenza
meditata di un filosofo, è chiaro che viene voglia di tacere per sempre.
Quando
la sua fama devastante è cominciata, con Cent'anni di solitudine,
Garcia Márquez si è inventato uno scongiuro per non essere sepolto
dalle foglie morte della vanità: ripeteva dentro di sé che lui era
solo il figlio di un telegrafista di Aracataca. Da allora è passata quasi
la metà di cent'anni. Non solo il suo anonimato e la sua povertà
si sono trasformati in fama e ricchezza, ma adesso ci sono centinaia di professori
in tutto il mondo che vivono grazie agli studi sulla sua opera, decine di giornalisti
che si guadagnano da vivere cercando di imitare i suoi reportage, biografi che
conoscono la sua vita meglio di lui e scrittori che per vivere lo incensano o
lo criticano a seconda dei loro umori gastrici, letterari e politici.
Alfonso
Reyes, alla fine di La experiencia literaria, e lo stesso Garcia Márquez
nel primo volume delle sue memorie (che a quanto pare sarà l'unico), ricordano
una polemica scoppiata in Colombia a metà del novecento. Potremmo chiamarla
con il titolo scelto dal poeta Eduardo Carranza per il suo intervento nella discussione:
un caso di bardolatria. Bisognava stabilire se Guillermo Valencia fosse il più
grande poeta colombiano - una sorta di Dante o di Lucrezio - come affermava Sanín
Cano o se invece, come affermava Carranza, era "solo un bravo poeta"
che aveva forzato la letteratura colombiana nel gelido corsetto del parnassianesimo.
Il commento di Reyes sulla vicenda è elegante come sempre. Senza lasciarsi
trasportare dalla passione, afferma: "Quando un sistema di espressioni si
consuma per il semplice corso del tempo e non perché manchi di per sé
di qualità, il massimo che possiamo dire è: 'Quelle cose che hanno
emozionato gli uomini di ieri, perché per loro erano invenzioni e sorprese,
a me non dicono più nulla. Ho assorbito a tal punto questo alimento che
ai miei occhi si confonde con le cose ovvie. Ringrazio chi mi ha nutrito e continuo
per la mia strada in cerca di nuove conquiste'. Ma mai avremo il diritto di negare
il valore reale, ormai immutabile nel tempo e nella verità poetica, che
tali opere o espressioni hanno rappresentato e rappresentano, perché nell'ordine
dello spirito ogni cosa resta sempre ciò che è stata".
Con
Garcia Márquez è difficile non cadere nella bardolatria che provava
Sanín Cano per l'opera di Valencia, ma nel caso dello scrittore di Aracataca
i motivi per farlo non mancano. È difficile non essere gabolatra: se la
sua ombra ha offuscato alcuni grandi scrittori colombiani della seconda metà
del novecento (come Manuel Mejía Vallejo e Germán Espinosa), non
è successo perché l'abbiamo fatto salire su un piedistallo immeritato,
ma per la sua stupefacente capacità di raccontare la nostra realtà
e la nostra storia con un talento e un fascino sovrannaturali.
Ma c'è
dell'altro, e forse è su questo che puntano i gabofobi quando attaccano
Garcia Márquez da un punto di vista letterario e non per le sue scelte
politiche: il paese è cambiato, forse in peggio, e le nostalgie che hanno
guidato quell'opera immensa e inimitabile non hanno più la stessa mitica
risonanza per le nuove generazioni. Il mondo è un altro, le nostre infanzie
sono diverse, e alcune ricette del realismo magico si sono logorate, non per opera
del suo autore più grande, ma per la stanchezza che ci procurano i suoi
peggiori e numerosissimi epigoni. L'arma meravigliosa dell'esagerazione (abusata
e consumata da altri) suscita già in alcuni l'indifferenza dell'abitudine.
A
volte Jorge Luis Borges sembrava imitare se stesso, e allo stesso modo alcune
pagine di Garcia Márquez, soprattutto le più recenti, sono scritte
con la solita tecnica impeccabile, ma senza il sangue e il midollo vitale che
le animava all'inizio. Lui stesso se ne è reso conto, e credo che il silenzio
degli ultimi anni sia dovuto al fatto che ormai sapeva di scrivere per inerzia
e non più in modo viscerale. Adesso Garcia Márquez ha la discutibile
fortuna di essere un monumento vivente e di vedere che i suoi libri non sono più
proibiti (come succedeva quarant'anni fa in alcune scuole colombiane), ma anzi
sono prescritti a cucchiaiate agli studenti come i canti di Omero e i capitoli
del Don Chisciotte. Così è facile diventare più venerato
che letto, ed è ancora più facile prendersi gli applausi quando
i gabofobi si lanciano in polemiche e insulti.
La nonna di Garcia Márquez
diceva che suo nipote Gabito era un indovino. Da indovino a divino la distanza
è poca. Non bisogna fare quel passo: Garcia Márquez è stato
e continua a essere un grande scrittore di questo mondo. Ha scritto romanzi immensi
che, se lo spagnolo sopravvive, si continueranno a leggere per secoli. Chiedere
di più è impossibile e dire di più è idolatria.
La
speranza, per i suoi conterranei come me, è riuscire a trovare il modo
per non insultarlo e per non trasformarlo in un dio, per non salire sulle sue
spalle sperando di vedere più lontano (perché in letteratura non
esiste progresso) e per non imitarlo appoggiandoci alle sue invenzioni. Dobbiamo
proseguire per la nostra strada senza imitare il suo stile, ma prendendo a modello
la sua vitalità, l'amore per l'arte e la fiducia nel fatto che la letteratura
è uno strumento meraviglioso per "svelare i segreti del mondo".
(Articolo tratto dalla rivista
Internazionale n° 688, del 19 aprile 2007.)

Héctor
Abad è
uno scrittore e giornalista colombiano, nato a Medellín nel 1958. In Italia
ha pubblicato Trattato di culinaria per donne tristi (Sellerio 1997).

 Precedente Successivo
Precedente Successivo
  Copertina
Copertina
|
