
 IL MERCATO
IL MERCATO
– Brano tratto dal romanzo Diario di un anno difficile –
J. M. Coetzee
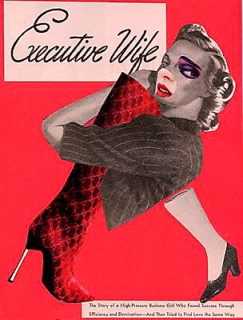
Secondo Judith Brett, nel suo recente saggio sull'Australia di John Howard, l'Australian Liberal Party, come Margaret Thatcher, non crede nell'esistenza della società. Ovvero ha un'ontologia empirica secondo la quale, a meno che tu non possa prendere a calci una cosa, la cosa in questione non esiste. La società, ai suoi occhi e a quelli della Thatcher, è un'invenzione dei sociologi accademici.
Le cose che esistono per i liberali sono (a) l'individuo, (b) la famiglia, e (c) la nazione. Famiglia e nazione sono i due raggruppamenti oggettivamente esistenti (nel senso che li si può prendere a calci) nei quali rientrano gli individui. L'individuo appartiene ineluttabilmente, per nascita, alla nazione e alla famiglia. Ogni altro raggruppamento tra il livello della nazione e quello della famiglia ha un carattere volontario: come si può scegliere una squadra di calcio, o anche scegliere di non avere una squadra, così si può scegliere la propria religione e perfino la propria classe.
Potrebbe sembrare che ci sia qualcosa di ingenuo e anche di limitato nella convinzione di Howard che, semplicemente col duro lavoro e col risparmio, ci si possa liberare delle proprie origini ed entrare a far parte della grande Australia senza classi. D'altra parte quello che Howard vede come unicamente e tipicamente australiano è proprio una certa diffusa buona volontà che incoraggia le persone a sollevarsi dalle circostanze in cui sono nate. (Qui il contrasto che vede è con la madrepatria, il Regno Unito, dove sottili legami ancorano le persone alla classe in cui sono nate). E la fortuna dei tempi del benessere sembrerebbe confermare la visione di Howard: una bella fetta della borghesia australiana - borghesia secondo i criteri economici, che sono gli unici interessanti per i liberali - viene dalla classe operaia.
I limiti di questa visione semplicistica della società emergono nelle questioni che riguardano la razza e la cultura. Un'Australia non razzista è, agli occhi dei liberali, una terra in cui non esisto-no barriere che impediscano alle persone di discendenza aborigena o di qualunque altra discendenza di diventare a tutti gli effetti membri della nazione australiana e di partecipare («giocare») a pieno titolo nell'economia del paese. Per godere pienamente dello status di australiano si richiedono solo energia, duro lavoro e fiducia in se stessi (a livello individuale).
Un analogo ottimismo ingenuo regnava tra i sudafricani bianchi benpensanti dopo il 1990, quando fu cancellato il criterio delle quote di lavoro fisse in base alla razza di appartenenza. Per loro la fine dell'apartheid significava che non ci sarebbero più state barriere per le persone e che, indipendentemente dalla razza di appartenenza, tutti avrebbero potuto realizzare il loro pieno potenziale economico. Così rimasero perplessi quando l'Anc introdusse una legislazione che privilegiava i neri sul mercato del lavoro. Per i liberali non avrebbe potuto esserci una mossa più retrograda, un ritorno ai vecchi tempi, quando il colore della pelle contava più degli studi, o delle aspirazioni e della laboriosità.
I liberali, in Australia come in Sudafrica, pensano che debba essere il mercato a decidere chi debba salire e chi no. Il governo dovrebbe limitare il suo ruolo: creare le condizioni all'interno delle quali gli individui possano portare le loro aspirazioni, la loro vocazione, la loro formazione, e qualsiasi altra forma di capitale intangibile possiedano, al mercato che poi (e qui è il momento in cui la filosofia economica si trasforma in fede religiosa) li ricompenserà più o meno a seconda del loro contributo (del loro «input").
Pur essendo nato prima, di fondo sono stato educato alla stessa scuola di pensiero, con la sua diffidenza nei confronti dell'idealismo filosofico e delle idee in generale e il suo spietato indivi-
dualismo competitivo, la sua ottusa concezione di promozione personale e la sua etica del duro lavoro. Ai tempi miei però mancava l'ottimistica fede nel mercato. Il mercato, mi spiegava mia madre, era una macchina cupa e sinistra che stritolava e divorava centinaia di destini per ogni individuo che ricompensava. La generazione di mia madre aveva un atteggiamento decisamente premoderno nei confronti del mercato: era una creazione del demonio; solo i cattivi soggetti prosperavano nel mercato. Per il duro lavoro non esisteva una ricompensa certa su questa terra; e nondimeno senza duro lavoro non c'era ricompensa di sorta, salvo, naturalmente, nel caso dei cattivi soggetti, gli «imbroglioni». Era una forma mentis rafforzata dai romanzieri che prediligevano: Hardy, Galsworthy e i naturalisti tragici.
Da qui la stupida ostinazione con cui perseguo i miei piccoli progetti, ancora oggi. Testardamente convinto che la fatica sia cosa buona di per sé, che porti o meno a risultati visibili. Un economista razionalista che osservasse la mia storia sorriderebbe e scuoterebbe il capo.
«Tutti partecipiamo al gioco del mercato globale: se non partecipiamo alla competizione siamo finiti». Il mercato è dove siamo noi, dove ci troviamo. Come siamo. finiti qui non è permesso chiedere. E come essere nati da genitori sconosciuti in un mondo che non ci siamo scelti. Siamo qui. Questo è tutto. Competere è il nostro fato.
Non ha senso cercare di spiegare che non ti piace la competizione con i tuoi simili, e che preferisci ritirarti, a chi davvero crede nel mercato. Se vuoi puoi ritirarti, ti diranno, ma di sicuro i tuoi rivali non lo faranno. Appena metti giù le armi ti massacreranno. Siamo ineluttabilmente costretti alla guerra di tutti contro tutti.
Ma di certo il mercato non l'ha fatto Dio - Dio o lo Spirito della Storia. E se lo abbiamo fatto noi, esseri umani, non dovrebbe essere possibile disfarlo e rifarlo in forma più accettabile? Perché mai il mondo dovrebbe essere un'arena in cui si scontrano i gladiatori - mors tua vita mea - piuttosto che, per esempio, un industrioso alveare o un termitaio cui tutti collaborano?
A favore dell'arte si può dire almeno che per quanto ogni artista tenda a dare il meglio, i tentativi di far apparire la sfera artistica come una giungla competitiva non hanno avuto successo. Alla finanza piace sponsorizzare gare artistiche, ed è sempre stata entusiasta di investire negli sport agonistici. Ma, diversamente dagli sportivi, gli artisti sanno che non è la gara che conta, è solo uno spot pubblicitario collaterale. Insomma gli occhi degli artisti in conclusione non si concentrano sulla gara, ma sul vero, il buono, il bello.
(Interessante come l'avanzata dell'individualismo mercenario ti spinga nell'angolo dell'idealismo reazionario).
E che dire dell'Australian Labor Party? Avendo subito una sconfitta elettorale dopo l'altra, l'Alp oggi viene criticato per aver reclutato la sua leadership all'interno di una casta politica troppo ristretta, attingendo a gente priva di qualunque esperienza che non sia quella politica e di partito. Non metto in dubbio la giustezza della critica. Ma quello che fa l'Alp è tutt'altro che unico. Però concludere che poiché in una democrazia i politici rappresentano le persone allora i politici sono persone rappresentative è erroneo. La vita avulsa dell'uomo politico somiglia fortemente a quella dei militari o della mafia o delle bande di banditi di Kurosawa. Si comincia la carriera al fondo della scala, andando in giro a fare commissioni e spiando; una volta dimostrata lealtà e obbedienza, nonché la propria disponibilità a sottoporsi alle umiliazioni rituali, si viene ammessi nella banda vera e propria; dopodiché si risponde prima di tutto al capobanda.
Brano tratto dal romanzo Diario di un anno difficile, Einaudi editori, Milano, 2008. Traduzione di Maria Baiocchi.

J.M. Coetzee ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura nel 2003.
 | I Saggi | La Narrativa | La Poesia | Vento Nuovo |